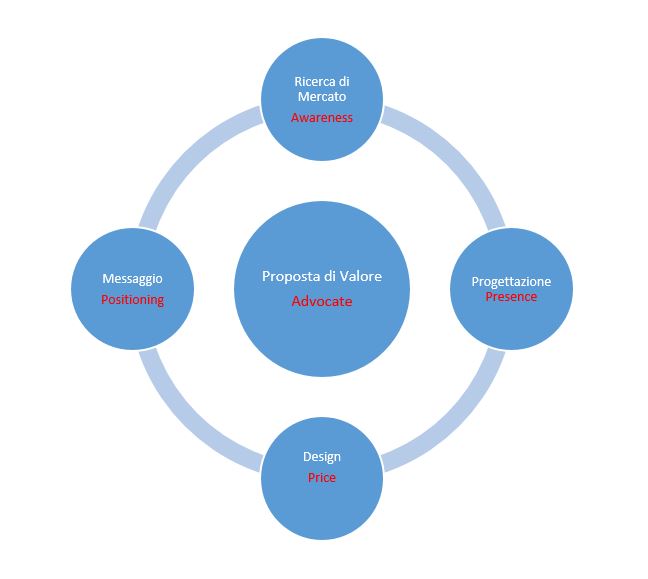Emanuele Fontana. Il Ristorante come metafora. L'organizzazione in cucina e l'arte di lavorare bene. ed.…

Una giornata come tante altre.
Il nonno aveva fatto in tempo a raccontarmi la sua avventura, la parte più bella della sua vita, che aveva acceso l’entusiasmo di un giovane soldato e spento l’ambizione di un uomo votato alla mediocrità; riscattandolo alla gloria di quel periodo, unico, irripetibile secondo il suo punto di vista.
Per prima cosa era fuggito da un campo di prigionia italiano, operativo per quasi tutta la seconda guerra mondiale vicino al piccolo centro dove ero nato io, ma presto dimenticato, subito dopo la liberazione, rimosso dalla memoria collettiva di tutti gli abitanti del luogo, in un niente.
Forse pudore, forse ignoranza o semplicemente voglia di voltare pagina, di quel campo si ricominciò a parlare dopo quaranta anni, solo per dire: “c’è stato un campo di prigionia qui”.
E dire che era fornito, attrezzato per ospitare un migliaio di prigionieri, in baracche indipendenti, con sbarre alle finestre e tetti di mattoni rossi. Mio nonno era finito lì subito dopo l’avanza in Russia dell’armata organizzata dalla Wermacht con poveracci provenienti da mezza Europa, Germania non esclusa, comunque.
Per un strano scherzo del destino, mio nonno, figlio di contadini poverissimi, morti di freddo in quegli anni, che servivano la terra a sud di Mosca, in un villaggio dal nome impronunciabile e presto dimenticato, fu catturato nei primi giorni di combattimento e deportato fino in Italia con gli altri prigionieri presi per strada, quasi tutti di origine slava.
Diciassettenne analfabeta, non parlante che uno strano dialetto russo, acquisì identità, sapere, dignità nel campo di prigionia, grazie ad un martire di Lubianca, nostalgico dell’adriatico nord orientale. Un comunista, cioè, come avrebbe detto Pavese, un operaio che ha letto tanti libri e che antepone la felicità degli altri alla sua. O meglio vorrebbe infine che tutti fossero felici.
Morì dopo la liberazione, senza vedere il suo Adriatico, mio (suo) padre? lo seppellì in un cimitero di campagna, dove per molti anni rimase in piedi una pietra di fiume, un gran sasso verde scuro, solcato dalla muffa. Accanto un fiore, semplice, rinnovato ogni settimana. N1235 scolpito da mio nonno sul sasso. Wladimiro, il suo nome, sarebbe stato ricordato a memoria di uomo, per una o due generazioni.
Ma l’avventura che mio nonno, vecchissimo, fece in tempo a narrarmi non riguardava la vita del campo. Quella fu la partenza, la base della sua formazione. Drammaticamente invigorita da morte, dissenteria, violenza. Dove impari a tenere alta la tua dignità per non morire: unica fuga possibile e sensata. L’avventura, quella vera, cominciò con la liberazione da campo, con l’andirivieni dei partigiani e dei tedeschi in zona, con l’arrivo poi del fronte e su, al nord, a seguire le truppe americane, fino alla fine, fino alla vittoria. La loro vittoria, di quei prigionieri prima ancora della gente che avevano contribuito a liberare.
In fondo quei soldati, i partigiani, i combattenti non desideravano la pace, desideravano la vittoria, unico modo per riscattare anni di tormenti e morte.
È questo che nessuno ha mai capito, non si lotta per ristabilire la pace, si lotta per la vittoria, per il riscatto della propria dignità. Ogni combattente lo sa, tutto il resto non serve a giustificare niente di più che le coscienze di chi crede che la morte non faccia parte della vita ma sia una ineluttabile disgrazia da tenere lontana.
C’è anche chi parla di rivoluzione, ovvero di organizzazione di persone per muove contro qualcosa, rovesciare un pensiero, una strategia di governo, le sue istituzioni, le sue appendici materiali. Non esiste che la rivolta individuale dell’uomo che chiede dignità, riscatto. Senza nessun tipo di organizzazione possibile se non la quotidiana lotta contro chi vuole sopraffare e inibire la libertà di ognuno. Ecco che uomini in rivolta, si affiancarono a soldati mandati da altri mondi, per vivere, combattere, fieri e sanguinosi, fino alla vittoria.
Dopo quegli eventi iniziò un’altra vita per il nonno, che lo portò a studiare, fare l’operaio e infine il bibliotecario, con grande soddisfazione, senza tuttavia ma più ritrovare la pienezza di quegli anni. Ecco spiegato il suo malinconico, profondo sguardo di schiavo circasso liberato.
Era infatti un uomo bellissimo in gioventù, geneticamente figlio della steppa, alto, moro, occhi verdi scuro – questi si notavano anche nel volto emaciato da vecchio.
I servi della gleba dai quali discendeva avevano mischiato così tante volte razze e desideri che ne era venuto fuori un uomo senza caratteri somatici decisamente riconducibili ad una latitudine in particolare, quindi, per i nostri criteri, un occidentale. Culturalmente poi un vero apolide, degno erede di un mondo nomade.
“Fa troppo freddo qui, meglio tornare indietro”
Disse il giovane combattente in uniforme riverniciata di verde inglese, appartenuta ad una guardia del campo di prigionia 4422 – Centro Italia.
Parlava italiano molto bene quel giovane bello e robusto, che aveva saputo sfruttare i 18 mesi di detenzione per imparare a leggere e scrivere sia in cirillico che in caratteri occidentali, in russo e italiano. E ora, senza alcuna difficoltà sapeva cosa dire in inglese per farsi riconoscere. Sarebbe comunque stato difficile scambiarlo per una spia tedesca.
“Aspettiamo ancora un momento. Cerchiamo di capire meglio quanti sono sti maledetti”.
Era freddo davvero, qualche grado sotto zero, umidissimo, una di quelle giornate insopportabili, con gli abiti gelidi che non di rilasciano un briciolo di conforto.
Il capo pattuglia non era mio nonno ma l’altro italiano, commilitone fascista fino a qualche mese prima, poi alla macchia dedicato con tutta l’anima. Non aveva mai combattuto in Africa, dove era stato assegnato alla divisione rifornimenti.
Per la verità non aveva ancora combattuto nemmeno in Italia. Dal momento dell’arrivo in quella squadra, o banda, come volevano essere chiamati e ricordati, aveva solo svolto azioni di ricognizione. Con mio nonno o con altri.
Soffriva il freddo in modo magistrale, battendo sempre i denti, scagliando imprecazioni fra le labbra troppo turgide persino per essere umide.
“Ecco, finalmente li ho visti tutti, mancavano quei due appartati dietro il capanno della legna. Forse erano di là a fare altro. In tutto quindi sono sei”.
“Stanno lì aspettare morte”.
Non proprio accurato l’italiano del nonno in quel periodo. Ma già caustico, terribile nella sua lucida spietatezza.
Scriveva anche peggio ma scriveva. Leggeva meglio.
Considerando che contemporaneamente aveva appreso anche a leggere e scrivere, male, nei caratteri del cirillico, poteva ritenersi fortunato, o sulla via di esserlo.
“Andiamo, è l’ora. Qui abbia fatto tutto”.
I due si incamminarono nel bosco, faticando a scansare le fronde, stando attenti ai sassi, tutto appariva bagnato, lucido, scuro.
Discendendo una scarpata con minimo dislivello intravidero in sfondo, di là dalla strada, una pattuglia di Gurkha, i feroci combattenti indiani, coloniali dell’Inghilterra.
I governanti del popolo che dispregiativamente veniva additato dagli italiani come quello dei cinque pasti a giorno, avevano organizzato bene la loro avanza nella penisola. In avanscoperta i Gurkha, feroci quanto sacrificabili, dietro le truppe dell’esercito inglese, i regolari del Re d’Inghilterra.
Le atrocità della guerra, le morti, la sofferenza, tuttavia non risparmiò nessuno, Gurkha o Inglesi che fossero. Dopo anni di guerra tale consapevolezza era comune a tutti.
“Papà, dove tedeschi?”
Domandavano con quel codice non ossequioso, ma efficace. Gli Italiani un po’ più maturi erano tutti Papà.
“Avanti, sono in sei”
Indicava il capo pattuglia, facendo segno con il dito pollice riverso nella direzione contraria rispetto a dove stavano procedendo.
“Proviamo a seguirli”.
Il nonno voleva vedere l’azione, aveva capito cosa avrebbero fatto. Non sarebbe stato comunque difficile immaginarlo.
Non fu facile, perché i 18 Gurkha procedevano a ranghi sparsi, chiudendo di fatto ogni via di fuga da quel lato. A distanza di tra quattro metri l’uno dall’altro si stavano velocemente avvicinando all’obiettivo.
Fu un attimo, un feroce attimo di fuoco. Da un lato dall’altro entrarono nell’aia dove i tedeschi si stavano radunando. Fecero fuoco con precisione, accortezza, senza scampo per alcuno.
Due dei Gurkha raccolsero velocemente le armi, un solo tedesco ancora urlava. L’attenzione che si riservò in questo modo non andò oltre ad un attimo. Un coltello enorme gli recise la giugulare.
Tutto, assalto, scariche di mitra, urla, coltello, raccolta armi, riordino e incendio della capanna, ebbe la durata complessiva di tre minuti, più o meno.
In ordine sparso rientrarono nel bosco successivo, lasciando al nonno e al partigiano la sensazione di non essere sufficientemente preparati per fare altrettanto.
Come ti sei sentino nonno, come hai fatto a vedere, sopportare, quel flagello. Ovvio che avevi alle spalle un mondo duro, controverso, spietato. Avevi inoltre sofferto la fame, la sete, le privazioni in un campo di prigionia. Avevi quindi già visto morire la gente di morte violenta, e di dissenteria.
Strappati alla vita con violenza, spauriti negli occhi, increduli che finisse così, senza speranza.
Avevi già visto sguardi disperati, soffi di vita impura, ormai prossimi a placarsi. Nelle ultime concitate sequenze di una morte si assiste alla atroce sofferenza, non più fisica, della paura. La paura del buio, della solitudine. La paura, dopo anni o mesi, o giorni passati a rendersi conto della presenza cosciente, del movimento almeno, di esistere a sé stessi. Nella ritualità dell’istinto, nella fermentazione della vita biologica, e, questi esseri umani arcaici mammiferi, anche e soprattutto con la conoscenza di un attimo. La paura di finire in niente. L’Avevi già vista, subita.
Con quei tedeschi trucidati in pochi secondi, appesi ancora alle loro baionette, iniettati di piombo, sorpresi a bocca aperta. Ora riversi sull’aia. Tutti morti in un niente. Carne putrefatta in anticipo sull’azione dei microbi.
I Gurkha conoscono la morte e la paura. Come cani prossimi a fare il loro bisogno in un angolo, anche loro andarono allora dietro la siepe, o dietro la baracca, dispersi, in un attimo di pudore. Non era un controllare se ci fossero stati altri tedeschi. Era solo la ricerca di un attimo, individuale, di pace. Non pentimento ma pace. Sangue che scorre, senza lamenti però, e loro dietro alla siepe o alla baracca. Un attimo appunto, per rendere masticabile la morte di quelle carcasse.
In fondo una forma di rispetto per altri combattenti.
Il capo pattuglia non disse niente. Non si guardarono fino al campo. I Gurkha divennero un pensiero già vecchio, nel momento in cui sparirono, in ordine sparso.
“Bentornati ragazzi”.
Era il comandante Nuvolo, sostituto di Franco, morto qualche giorno prima.
“C’è un pezzo di pane, ci sono anche due uova da metterci accanto. Un rinforzino avremmo detto un tempo.”
Nuvolo era sarcastico al punto giusto, molto intelligente e colto. Aveva fatto l’insegnate di scuola superiore fino allo scoppio della Guerra. Non richiamato perché già quarantenne. I morti, in Italia e nel mondo, dovevano avere vent’anni, sufficienti per piangerli con decoro.
Alla macchia non si chiedevano generalità se non per capire se si fossero spie o meno. Quindi data l’età, il grado di istruzione, e un certo saper fare con i giovani, il professore di Chimica del Liceo Mussolini, era divenuto comandante di una banda.
Gli altri dormivano tutti, o facevano finta di dormire, quando il nonno e il capo pattuglia si misero da parte per mangiare pane con uovo.
Detesto le uova, questo lo dico io, le ho sempre detestate ma non certo perché le mangiava il nonno. Anzi, comprendo il loro valore nutritivo ma odio l’odore, il sapore. Penso che anche con tanta fame non le toccherei. Almeno così ci si immagina di fare. Poi, il freddo, l’umido, le mutande sporche, la sete e la fame atroce che ti prendono per giorni e giorni, penso convincano tutti a mangiarsi qualsiasi cosa. Anche a costo di vomitarla. Almeno i succhi gastrici si muovono un po’.
Un ex sergente che aveva l’idea della vita militare, uno degli altri dodici componenti la banda, oltre ai due divoratori di uova e a Nuvolo, chiese la redazione del rapporto, come lo chiamava.
Assente carta e penna i rapporti, che Nuvolo chiamava resoconti, erano orali, sintetici e strigati come il vocabolario permetteva.
Così con il pane ancora nel gozzo, l’uovo a rinfrescare il bolo da ingurgitare, ecco che il nonno, molto sinteticamente fece il suo rapporto. L’altro non ebbe da aggiungere niente. Esprimeva con la testa e lo sguardo teso il suo pieno assenso alla versione del nonno. Si avvaleva pertanto della facoltà di capo di far parlare altri, al suo posto. Riepilogare il drammatico avvistamento, la velocità dei Gurkha, la loro freddezza. Il lavoro fatto, aveva risparmiato munizioni alla banda, nonché concesso tranquillità per le prossime ore.
Il terreno era sgombro dai crucchi. Le armi, interesse principale del sergente, erano state prese dai Gurkha. Forse, avrebbero trovato qualche coltello e borracce per l’acqua. Gallette o cose del genere commestibile non erano potenzialmente ritrovabili.
“Marceremo nel pomeriggio, per superare quella vallone e riaccamparci stanotte di là dalla collina. Adesso Riposate, come riposano tutti. Qui è sicuro. E senza quei tedeschi nelle vicinanze siamo tutti meno tesi”.
Era Nuvolo, che da dietro il Sergente, aveva dato l’ordine più logico. Non si combatte oggi, si sopravvive e ci si attesta, sull’altro crinale. Da lì non sarebbero stati che a pochi chilometri dalla città. In attesa degli eventi.
Alla banda si era unito per sorte il nonno. Con il semplice desiderio di mangiare. Poi, considerata la distanza da quella che poteva sembrare una casa, una patria, il luogo della sua memoria, non fece altro che aderire alla lotta partigiana con tutto sé stesso. Unica ragione di una vita che da quel momento prendeva una piega definitiva. Nulla sarebbe più stato lo stesso dopo aver incontrato i commilitoni, i partigiani eroici, vestiti di stoffa grezza, a volte con fazzoletti rossi al collo, camicie sudicie, a quadretti, veramente poco mimetiche in un bosco.
Lui, dopo il campo, dopo lo sbandamento, dopo la fame atroce, dopo niente altro che marciare, dormire all’aperto, sentire freddo, bere acqua dal fiume, mangiare bacche, annusare fumo di minestra in aie troppo poco buie per nasconderlo agli occhi dei contadini.
Lui, il nonno straniero, trovò casa, famiglia, calore. La brigata partigiana lo accolse senza fare troppe domande, davvero quelle persone erano così impreparate, ma coraggiose, da sentire, solamente sentire di poter fidarsi di uno straniero, con un incerto italiano. Ma si vedeva la tristezza del campo, la pelle avvizzita ma ancora tendibile, di un giovane strappato alla vita nei campi, messo a combattere ferocemente su un fronte mobile, scampato alla morte, doppiamente. Così il campo di prigionia, era diventato la sua scuola, aveva sì rovinato la pelle giovane, non per sempre, ma lasciato quelle tracce di maturità che lo avevano fatto divenire un uomo: libero, forte, indefesso.
Assopiti nell’odore di erba umida, ghiande e acacie selvatiche pensavano all’azione, prima o poi da materializzarsi in una furia di urla e gemiti. Chi potrà sopravvivere, si domandava ognuno. Mio nonno penso lo sapesse che lui avrebbe superato incolume il periodo di guerra e carestia, e lunghe marce nel freddo.
Bastò una granata, dal chiocco maldestro, deflagrata con terribile forza subito dopo. Basto quella maledetta granata a decidere chi dei presenti non potesse giungere alla soddisfazione di combattere contro i tedeschi, a viso aperto, duri, sereni.
Due morti subito, poi Michele, falciato dalla raffica di mitra. I tedeschi erano da tutte le parti. Il nonno e il capo pattuglia, scapparono, rotolando più che correndo verso il greto del fiume. Nuvolo sparava e urlava. Urlavano tutti, sopresi, offesi quasi da quello squarcio nel loro torpore.
Tre o quattro tedeschi sparavano all’impazzata, correndo avanti e indietro per l’accampamento. Nuvolo ne travolse uno con una raffica di mitra. Gli altri capirono e andarono ad attestarsi dall’altra parte di un grosso ammasso di terra di riporto. Eco di antichi scavi.
I partigiani si radunarono quindi dalla parte di Nuvolo, dietro altri grossi sassi che emergevano dal terreno, pieni di muschio, freddi ma leggermente profumati.
Stirandosi di lato uno dei partigiani riuscì a scoprire il fucile e cominciò a trinciare le gambe dei tedeschi scoperti. Poi ancora granate a sferzare aria, a chiudere polmoni. Rimbombi terrificanti. Mio nonno non aveva avuto il tempo di capire come fare a difendersi. Solo la fuga era stata possibile ed ora giaceva, con il compagno sul greto del fiume, in attesa, con grande paura. I denti battevano, la pancia si contorceva da sola.
“Che fare”.
Disse all’amico.
“Aspettiamo che si calmino, poi su, in aiuto ai nostri. Prendiamo di lato. Vieni cominciamo a salire. Da quella parte forse riusciremo a vedere meglio”.
Ascoltavano tesi ogni botto, ogni scarica, le urla erano sempre più terribili. Due uomini erano venuti così vicino che né pistole né fucili erano più distinguibili.
A morsi, coltello, pugni sulla testa, si contorcevano a metà strada fra i tedeschi e i partigiani. Nessuno poteva sparare senza macchiarsi della colpa di aver ucciso un amico. Quindi nessuno sparò ai due, ma solo in orizzontale, verso i mucchi di terra e per converso contro i sassi muschiati.
I due in mezzo urlavano e imprecavano nelle loro lingue. Poi una raffica, e smisero di muoversi.
“Che hai fatto”
Disse il nonno. I due infatti erano risaliti fino ad una piccola altura che dominava i due schieramenti nemici, scoprendo i tedeschi.
Senza rispondere il partigiano con mio nonno ricominciò a sparare, raffiche efficaci, questa volta contro i sette tedeschi che furono colti al fianco. Caddero in quattro, agli altri ci pensarono i partigiani che intanto erano usciti in carica disperata verso di loro. Nuvolo non fece che tre passi, crollò sotto una fucilata precisa. Mio nonno intanto aveva seguito l’assalto e si era buttato sull’ultimo tedesco in piedi.
Come mi disse tanti anni dopo, con poca voce, gli occhi umidi, lo uccise con un solo fendente di coltello. Non aveva altro che quello, le munizioni erano finite.
La coltellata bisogna saperla dare, dalla pancia è necessario salire, con forza, in alto, per aprire tutto e scorgere anche da sotto i vestiti il sangue copioso e le prime budella nere.
Accanto a Nuvolo era caduto un altro partigiano, anche lui colpito in testa. Quindi non dai tedeschi asserragliati dietro i mucchi di terra. Aveva capito, il capo pattuglia, che ci doveva essere un cecchino più dietro, rispetto a quei tedeschi ormai morti.
Di colpo si accorse del tiratore, uscito imprecisamente da un folto cespuglio. Da un punto dove agli occhi degli altri niente di umano poteva esserci. Scaricò il mitra, lo seguirono gli altri che ancora avevano munizioni a sufficienza.
L’ultimo tedesco sputò tutto il sangue che aveva ma fece in tempo a lanciare una granata. Caddero altri partigiani. La morte arrivava da tutte le parti.
Finita la battaglia, finite le munizioni, finite le urla. Erano rimasti in sei, mio nonno, più coraggioso divenne il capo. Il capo pattuglia non si oppose, anzi fu lui, a ribadire che non avrebbe più sparato a nessuno, aveva ucciso, insieme ai tedeschi, anche il suo amico, il sergente. Quindi solo soldati semplici e un rifugiato russo. Con uno di loro che aveva appena dichiarato di fare obiezione di coscienza. Mai più uccisioni da parte sua.
Dopo aver raccolto le armi, selezionato le munizioni, recuperato gallette e altro cibo frugale – acqua ne avevano – si misero in marcia. Dovevano ancora passare dall’aia dove erano gli altri tedeschi morti. Poi sarebbero giungi, sfiniti, al poggio più lontano e di lì la vista della città.
Ogni mattina c’era qualcosa da fare. Trovare cibo, avvistare qualcosa, seguire un sentiero, contare cadaveri, seppellire qualcuno. Non c’era tempo per pensare a cosa sarebbe stata la vita senza guerra, senza fuga da un nemico sempre più nervoso, irrazionale, che saliva in alto l’Italia, in fuga, anche lui, da morte certa.
Quella mattina la casa in paese, dove si pensava fosse un partigiano, era ben sorvegliata da un plotone di tedeschi.
Un sergente della Wermacht andò svogliatamente a bussare alla porta.
Due commilitoni intanto avevano messo sotto tiro un vecchio, nel campo di patate adiacente.
“Un quintale, per mezzogiorno” Aveva detto in buon italiano quello alto, biondo.
“Sennò caput”.
Il vecchio, abituato, non disse niente, guardò la terra fredda e dura, rialzo gli occhi sui soldati e sputò per terra, piano.
Al bussare, sempre più forte, non si ebbe risposta. Niente faceva presagire qualcosa di buono. Nemmeno la calma del vecchio ora chino a cercare di strappare da terra qualche patata. Mai avrebbe recuperato un quintale.
Che misura strana quei tedeschi, un quintale di patate, da un campo di nemmeno dieci metri per dieci, ma con i tuberi, forse, appena avviati a maturazione.
Il vecchio pensava a chi avesse mai insegnato la parola quintale a quel tedesco. Sapeva che erano cento kili? Chissà cosa pensava che fosse un quintale.
Dalla finestra, finalmente una testa fece capolino, era una vecchia. Scuotendo il capo cerò di far capire che lì non c’era nessuno oltre lei.
“Aprire e vedere, aprire!”
Il comandante del plotone, un tenentino giovane, intimava al sergente di continuare, tenendo d’occhio anche il campo, i due soldati, il vecchio chino.
Non sapeva che dietro al muro, non lontano da lui ma in posizione favorevole, c’erano quelli della banda del nonno. La banda del russo, come si chiama da qualche tempo.
Erano tornati ad essere una decina, con l’aggiunta miracolosa di tre studenti liceali e due giovani meccanici fuggiti dal lavoro forzato in ferrovia.
Tutti armati, perché a forza di trovare corpi mutilati, seppellire compagni, uccidere tedeschi, scovare rifugi, bene o male, avevano tutti il necessario per dichiararsi partigiani, un fucile, un coltello, una buona scorta di pallottole.
“Aprite, aprite subito”. All’ultima vocale la porta si aprì improvvisa, feroce. Saltò in aria, un secondo dopo, il sergente e un sondato accanto. La granata del partigiano in fuga dalla casa aveva raggiunto il suo scopo.
Il corpo di Salvatore saettò fuori da fumo come un fulmine squarta le nuvole grigio scuro. Improvviso illuminarsi di un desiderio: la vittoria.
Fu il segnale che tutti stavano aspettando. I ragazzi della banda del russo cominciarono a sparare sui tedeschi, che cadevano, a bocca avanti, serrando gli occhi per la sorpresa.
Salvatore, fucile in mano, sparava a ripetizione contro chiunque. Colse in testa il tenente, che stramazzo anche lui ad occhi aperti.
Il babbo di Salvatore, il vecchio delle patate, intanto si era acquattato in terra, dentro un fossetto di confine. I due soldati con il loro bel secchio che avrebbe dovuto contenere il quintale di patate corsero via, lasciando i fucili a terra. Impauriti dalla sorpresa. Fu Salvatore a inseguirli, trasformando l’assedio, definitivamente in carica.
Il nonno, capo partigiano, saltò il muro, con la baionetta mise in fuga un altro tedesco. Con gli altri due furono gli unici a sopravvivere. Catturati dopo venti minuti di corsa inutile per i cortili e le stradine del paese. Vennero legati e fatti mangiare. Poi lasciati in piazza. Dopo tutti avrebbero potuto vedere. Vivi, perché i partigiani del russo non uccidevano invano.
E da lì al nord, sempre più a nord. Con la sua banda, con altri, con commilitoni nuovi, gente attempata, spie, traditori, doppi traditori. Tutti in uniformi troppo strette, o troppo abbondanti, sottratte ai cadaveri. Ogni tanto qualche spia saltava su e diceva che doveva andare a farla lontano. Per pudore. Non tornando svelava, dopo pochi minuti la sua identità. Quindi via, campo o serraglio, sacco in spalla e via, sempre più dentro le macchie. Uniche amichevoli case di legno e umidità.
I racconti del nonno non vennero mai registrati da nessuno, né tanto meno vennero presi appunti. Non lo si fa mai, poi dopo anni, si pensa a quel patrimonio perduto. Consolandoci con il fatto che comunque trattasi di micro storia, appendici di provincia di un grande e molto complesso scenario. Averne avuto dignitosamente un parziale riassunto basta a riempire il cuore. Non c’è necessità, in fine, della traccia vocale o della pagina scritta.
E poi tanto non si è fatto durante gli anni buoni, con i protagonisti in vita, cosa si vuol fare adesso, dopo tutti i rivolgimenti della quotidiana esistenza, se non ricordare e mandare un pensiero a quegli uomini, a quelle idee, a quel concetto di vittoria che nessuno, compreso il nonno, ha mai più avvicinato.
È rimasto un cognome, abbastanza originale, che mi ha segnato parte dell’esistenza, come a mio padre, perché italianizzarlo sarebbe stato inutile. Non abbiamo mai visto la tundra russa, né tanto meno il ghiaccio. C’è rimasto il cognome. Un argomento di discussione e, fino a che ci sarà l’interesse, lo spunto per raccontare storie di partigiani, di morte e di campi di prigionia. Il resto della storia è nota, non più interessante. Non oserei dire banale ma solo normale.